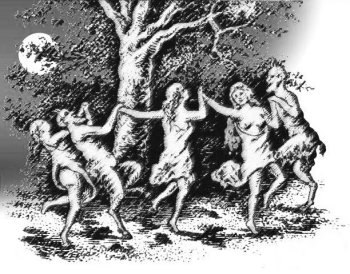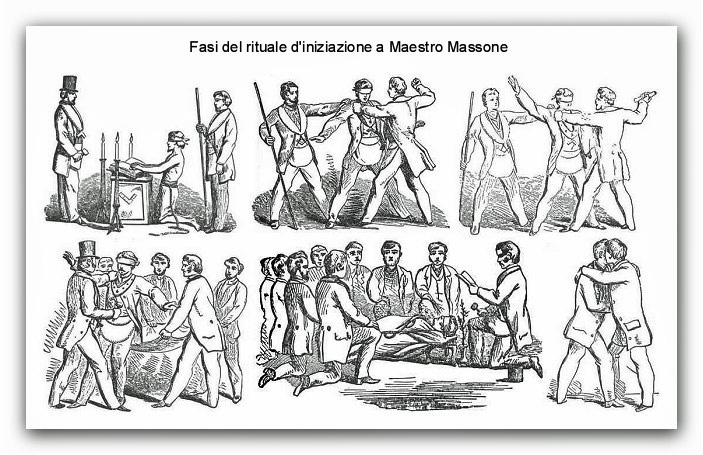TEATRO AUGUSTEO
Piazzetta Duca d'Aosta, 263 - Napoli - Tel. 081.414243 -
|  |
Il Teatro e la sua Storia
Nel 1922, per migliorare le comunicazioni con il rione del Vomero in continuo sviluppo, l'amministrazione comunale aveva approvato un progetto per una funicolare che, partendo da via Roma e sottopassando la via Conte di Mola, doveva portare fino al Vomero. Per creare uno sbocco al traffico della funicolare fu ideata una piazzetta all'uscita della stazione inferiore, realizzata con la demolizione di vecchi stabili ad angolo fra via Roma e via Conte di Mola. Questi stabili, o parte di essi, si ipotizza che abbiano
fatto parte della proprietà di Palazzo Berio, marchese di Salza. Il palazzo era stato fatto edificare nel '600 da un certo Simon Vaez, nobilitato Conte di Mola dal re di Spagna. Prima di passare nelle mani del marchese Berio, il palazzo, del quale si ignora la primitiva forma, fu dei Tomacelli, che nel 1772 diedero incarico a Luigi Vanvitelli di ridisegnarne la facciata. Sempre in quell'anno il grande architetto, in occasione del battesimo della Reale Infanta Carolina, costruì nel salone da ballo, che conteneva circa 1000
persone, un "teatrino" di 1600 posti, conservando la pianta a forma circolare del salone.
Il palazzo attraversò un periodo di grande splendore, soprattutto per l'ospitalità e la munificenza dimostrata dai proprietari nei confronti degli artisti. Infatti, Francesco Berio fu uomo di vasta cultura, poeta e collezionista d'arte e, non a caso, ancor oggi l'edificio, o almeno ciò che rimane di esso, è conosciuto appunto con il nome del marchese Berio che tanto contribuì a renderlo famoso. Quando nel 1820 il marchese morì, senza eredi maschi, per fare un'esatta divisione dell'eredità tra le quattro figlie si dovette vendere una parte dell'edificio, dando così il via al processo di decadimento dell'imponente e storica struttura. Anche se non ne si è certi si può ipotizzare che fra quegli stabili demoliti per lasciar spazio alla piazzetta ci fosse anche una parte di palazzo Berio, e non è da escludere, quindi, considerata l'attuale collocazione del teatro Augusteo, il cui palcoscenico è situato al di sopra della funicolare, che questo sia stato realizzato sulla struttura dell'antico teatro vanvitelliano.
Contemporaneamente alla realizzazione della funicolare, l'architetto Pier Luigi Nervi, uno tra i maestri dell'architettura contemporanea non soltanto italiana ma internazionale, tra il '26 ed il '29 realizzò questo imponente teatro, tra i maggiori a livello europeo rispetto all'epoca in cui fu costruito.
" Questa sera alle 21.30 precise con uno spettacolo di gala, al quale interverranno le maggiori autorità cittadine e la più elevata aristocrazia, si inaugurerà l'Augusteo, il più grandioso cine-teatro di Napoli, che la società Funicolare Centrale ha costruito con l'Anonima Pittaluga. Anticipare di poche ore il giudizio del pubblico ci sembra superfluo: i napoletani, varcando la soglia di questo nuovo locale, avranno la sensazione esatta di quanto è stato compiuto per dotare la nostra città di un cine-teatro, che per vastità, comfort, eccezionalità di spettacoli, sia uguale alle maggiori sale cinematografiche d'Europa e d'America. L'Augusteo, che è stato decorato da artisti valentissimi, come Carlo Siviero autore del velario e Ezekiele Guardascione, è capace di oltre tremila posti, dispone di un'immensa platea, di una vastissima galleria, di quattro ordini di palchi, di un colossale impianto di aerazione e di riscaldamento, di ascensori e scala mobile, costruzione della ditta Stigler. Al comfort di questo eccezionale cine-teatro hanno cooperato le migliori ditte italiane... Tutta Napoli sarà stasera all'Augusteo, che inizia la serie di grandi spettacoli col supercolosso Volga Volga. I prezzi dei biglietti che sono in vendita alle ore 18 alle casse del locale sono per questa sera i seguenti: galleria lire
15, sala lire 10, loggiato lire 5".
Così " Il Mattino " annunciava l'inaugurazione dell'Augusteo, con un articolo pubblicato il giorno 8 novembre 1929.
La scelta del nome, l'imponenza della struttura, la profusione di marmi e stucchi, rispecchiano il gusto e l'ideologia della classe dominante dell'epoca, che aveva voluto creare un luogo elegante, come punto d'incontro dell'aristocrazia e delle autorità politiche e militari. La volontà precisa di stupire il pubblico si rivela anche nella scelta della programmazione, che prevede sin dai primi mesi un susseguirsi di grandi " colossi " del cinema, con accompagnamento musicale di orchestre imponenti e cori d'eccezione. Infatti, nella realizzazione architettonica dell'Augusteo si era tenuto conto che tale struttura era destinata alla musica e al canto: di qui la sua eccezionale acustica. Grazie a questa sua peculiarità, l'Augusteo ospita cantanti del calibro di Tito Schipa, Beniamino Gigli, il tenore Giovanni Martinelli e i maggiori esponenti della canzone napoletana.
Dal novembre del 1929 al 10 gennaio del 1930, vengono proiettati film come " Il quartiere latino ", " Giglio imperiale ", " Nina Petrowna " con Brigitte Helm, " Orchidea selvaggia " con Greta Garbo, " Tradimento " con Emil Jennings, per la distribuzione delle maggiori case produttrici, come la Metro Goldwin, la Paramount, la Warner Bros. I films venivano spesso presentati o seguiti da balletti " di lussuosa presentazione sceneggiata ", come cita la presentazione del balletto di Bella Schumann, rappresentato dal
9 al 25 dicembre 1929 dopo la proiezione del film " Giglio imperiale ". Il 10 gennaio del 1930 venne proiettato per la prima volta il super colosso della cinematografia, " sonoro, parlato e cantato ": " L'arca di Noè "...
Il successo di pubblico fu inaudito: fino al 23 gennaio, 250 mila persone avevano assistito alla proiezione del film, che fu prorogato per altri due giorni rispetto alla programmazione per soddisfare le richieste del pubblico.
Dal mese di febbraio spesso i film cominciarono ad essere preceduti da pellicole per bambini, come " Topolino contro i gatti " e " Topolino pianista".
Questa cura dimostrata per il pubblico più giovane continua in seguito, con le " mattinate infantili " di teatro scuola e, comunque, sarà sempre una caratteristica di questo locale quella di ospitare i più diversi tipi di spettacolo.
Nel 1930 inizia il musi-hall, cui si affiancano Beniamino Gigli con il quartetto d'opera, balletti e danze moderne, tanghi argentini ed acrobazie.
Negli anni successivi la programmazione del teatro vede alternarsi cinema e riviste. Ospita illustri artisti italiani e stranieri, il 25 marzo 1932 debutta Josephine Baker con i balletti del Casinò di Parigi e danzatori americani. Il 9 aprile è il turno della "compagnia di rivista Bluette-Navarrini". Entrambi gli spettacoli furono un trionfo e l'Augusteo sempre più diventa il centro di ritrovo di tutta la " Napoli chic ". Nel 1934 c'è il debutto del teatro di prosa con Elsa Merlini e Sergio Tofano, una precisa scelta di programmazione del teatro, che volle dare un maggiore rigore nelle scelte e nella gestione del locale. Ma il grande evento di
quell'anno fu l'arrivo, il 30 marzo, della compagnia di Totò, che rappresentò le sue riviste fino al 13 aprile. Inutile dire che fu una
apoteosi di successo con il botteghino che registrò il tutto esaurito tutte le sere. Contemporaneamente l'Augusteo continua ad ospitare rappresentanti famosi, o destinati a diventarlo, della canzone napoletana. Il 14 agosto del '36 si esibisce " La Bottega dei Quattro ", che fa capo a Libero Bovio, Gaetano Lama, Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente e si avvalse successivamente della collaborazione di Ernesto Murolo.
Durante la guerra il teatro fu chiuso, per riaprire nel '45 sotto la gestione degli alleati che lo ribattezzarono " Red Cross Club " ( Club della croce rossa ).
Fino agli anni '50 l'Augusteo subì un arresto, fino a quando venne riaperto e ristrutturato. Cambiò dunque aspetto, e l'antico cinematografo-teatro venne stravolto dalla controsoffittatura che ne coprì la volta, mentre i quattro ordini di palchi vennero murati, e le porte e le mura della sala vennero nascoste dietro una pannellatura in legno.
Dalla metà degli anni '80 il cinema cominciò ad avere un netto calo e la programmazione diventò frammentaria ed occasionale, fino alla definitiva chiusura. Quello che era stato il glorioso teatro, salotto dell'antica via Toledo, acquistò l'aspetto di un buio e polveroso deposito; la stessa piazzetta Duca d'Aosta fu lasciata nel totale degrado ed abbandono.
Nell'autunno del '92, partita l'operazione di recupero con la disponibilità dell'Amministratore Unico della S.A.C.I.A.V., società proprietaria, Dott. Ettore D'Auria, e con Renato Abate da una parte, e Francesco Caccavale e Vincenzo Acampora dall'altra, la struttura originaria è stata ripristinata ed il locale riapre " alla città " come sala teatrale. Sul piano tecnico e progettuale, questa operazione è stata ideata e realizzata da Pippo Caccavale, che ne ha curato e diretto il recupero, la valorizzazione, la ristrutturazione e tutte le fasi del restauro.